L'emergere della cartolina nell'era della fotografia elitaria
Nel XIX secolo la fotografia rappresenta una tecnologia complessa e costosa, accessibile esclusivamente alle classi sociali privilegiate. Come documenta Susan Sontag in "On Photography" (1977), la fotografia ottocentesca richiede competenze tecniche specializzate e attrezzature onerose, consolidandosi inizialmente come pratica distintiva dell'aristocrazia e della borghesia emergente.
In questo contesto socio-tecnologico, le stampe fotografiche evolvono gradualmente da curiosità elitarie a strumenti di comunicazione di massa. La cartolina postale illustrata emerge come formato rivoluzionario: un supporto cartaceo rettangolare che combina l'immediatezza visiva dell'immagine fotografica con la funzionalità comunicativa del messaggio scritto. Secondo le ricerche di Orvar Löfgren (2001), la prima cartolina postale illustrata con fotografia risale al 1889, proposta in occasione dell'Esposizione Universale parigina, immortalando significativamente la Tour Eiffel, simbolo architettonico dell'evento e paradigma della modernità industriale.
L'iconografia standardizzata del turismo di massa
La seconda metà del XX secolo segna una trasformazione epocale: il turismo si democratizza, evolvendosi da privilegio elitario a fenomeno di massa planetario. Come analizza John Urry in "The Tourist Gaze" (1990), questa massificazione comporta la standardizzazione dell'esperienza turistica e, conseguentemente, della sua rappresentazione visiva.
L'avvento dell'era fordista e la democratizzazione delle pratiche turistiche determinano l'affermazione di un'iconografia codificata, sintetizzabile nella formula delle "4S": Sea, Sand, Sun and Sex. Questa standardizzazione iconografica riflette quella che Dean MacCannell (1976) definisce come staged authenticity: l'autenticità locale viene progressivamente sostituita da rappresentazioni omologate che rispondono alle aspettative turistiche globalizzate.
Le cartoline di questo periodo testimoniano l'emergere dell'eliotropismo come paradigma dominante. Sia le destinazioni balneari che quelle montane adottano un linguaggio visivo incentrato sulla centralità del sole, elemento unificante dell'immaginario turistico standardizzato. Questa omologazione iconografica riflette processi più ampi di globalizzazione culturale analizzati da Roland Robertson (1992) nel concetto di glocalization.
La diversificazione postmoderna e la rivoluzione digitale
Gli anni Novanta del XX secolo segnano una svolta significativa: la crescente frammentazione dei mercati turistici favorisce l'emergere dei cosiddetti "turismi di nicchia". Come documenta Poon (1993) in "Tourism, Technology and Competitive Strategies", questa diversificazione risponde alle esigenze di segmenti di mercato sempre più specializzati e alla ricerca di esperienze autentiche e personalizzate.
La vera rivoluzione è rappresentata dall'esplosione delle reti digitali, in particolare di Internet. L'avvento delle tecnologie digitali ridefinisce radicalmente i paradigmi comunicativi turistici. La cartolina tradizionale, pur mantenendo una presenza simbolica nell'immaginario vacanziero, deve confrontarsi con nuove forme di comunicazione: SMS, MMS, cartoline virtuali, blog e post ridisegnano le modalità di condivisione dell'esperienza turistica.
Come osserva Sheller e Urry (2006) nel concetto di mobile turn, la comunicazione turistica diventa istantanea, interattiva e multimediale, superando i limiti spazio-temporali della cartolina tradizionale. La digitalizzazione non elimina la funzione comunicativa della cartolina, ma ne trasforma profondamente le modalità e i significati, inserendola in un ecosistema mediale più complesso e articolato.
"Un ultimo aspetto del falso viaggio sono le cartoline illustrate, che occupano uno spazio spropositato nella mente del turista italiano. Raramente costituiscono una gioia. Spesso provocano ansia genuina. C'è chi ha sentito dire che spedire cartoline non è più chic, ma non sa come informare della novità gli anziani genitori; chi non sopporta di sprecare tempo prezioso umettando con la lingua i francobolli, e si lamenta che qualche sadico li faccia sempre più grandi; chi va in vacanza da qua-rant'anni a Nizza e non sa più che cartoline spedire, perché ormai ha esaurito tutte le possibili angolature di Nizza.
Tutti costoro potrebbero salutare con entusiasmo l'iniziativa di un pensionato del Connecticut di nome Palmer Chambers, il quale, dopo aver abbandonato il commercio per corrispondenza delle vitamine, ha fondato la società «Beforehand Cards» (Cartoline preventive) e soccorre i vacanzieri in questo modo: basta segnalare con buon anticipo l'itinerario del proprio viaggio, e vengono recapitate le cartoline illustrate dei luoghi in questione. L'acquirente le scriverà prima di partire. Arrivato a destinazione, non perderà un minuto delle proprie vacanze. Le cartoline non dovrà più acquistarle, scriverle e indirizzarle. Le avrà già in tasca, pronte: dovrà semplicemente imbucarle.
Tutto questo è valido in teoria. Potrebbe funzionare, cioè, con un popolo diverso da quello italiano. In Italia il signor Chambers — il quale assicura di avere in archivio panorami e tramonti provenienti da cento-trenta Paesi del mondo — incontrerebbe serie difficoltà. Innanzitutto, gli italiani si muovono per il mondo come se avessero la tarantola, ed è certo che le prime richieste riguarderebbero i quaranta Stati che non sono nell'archivio (Turks e Caicos, Burkina Faso e sultanato del Brunei). Un altro problema sarebbe quello della scelta delle cartoline. Se gli americani appaiono facili da accontentare — di solito sono felici con una fontana e, quando li trovano, con i grattacieli — gli italiani hanno gusti più complicati. Esistono gli appassionati delle vedute aeree, che spediscono praticamente la stessa cartolina da trent'anni: che siano a Bordeaux, a Urbino o a Dublino mandano sempre l'identica immagine di tetti rossi che sembra ripresa da una sonda spaziale. All'estremo opposto stanno gli appassionati dei dettagli artistici, i quali spediscono solo le ali di angeli affrescati e gli occhi bovini delle statue. È chiaro che il signor Chambers del Gonnecticut, qualora si vedesse richiedere una cartolina con l'immagi-, ne dell'angelo della navata di sinistra della chiesa di Nostra Signora delle Nevi a Praga, potrebbe avere qualche difficoltà.
Altre sorprese seguirebbero. Gli italiani, dicendo di detestarle, amano le cartoline illustrate perché permettono di esercitare anche in vacanza quello che resta il grande passatempo nazionale: lamentarsi. Una cartolina acquistata sul luogo di villeggiatura permette infatti di protestare per: a) il costo della cartolina stessa; b) la difficoltà di reperire i francobolli; e) la scocciatura di doversi portare appresso l'agenda con gli indirizzi; d) il fatto che sull'agenda l'indirizzo richiesto sia sprovvisto di numero civico e codice postale; e) l'obbligo, se si scrive a un parente, di scrivere anche a tutti gli altri; f) la difficoltà di trovare una frase originale (l'alternativa, alla fine, si riduce a «cari saluti» e «molti saluti»; gli stranieri vergano invece lunghe missive, andando a scrivere anche tra i dentini dei francobolli). Tutti questi problemi costituiscono deliziosi argomenti di conversazione, e consentono di trascorrere piacevoli giornate in compagnia sulle spiagge, negli atrii degli alberghi e nelle sale d'attesa degli aeroporti del mondo."
Beppe Severgnini, Italiani con valigia : il Belpaese in viaggio, Rizzoli, 1993
Fonti principali
MacCannell, D. (1976). The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. University of California Press.
Poon, A. (1993). Tourism, Technology and Competitive Strategies. CAB International.
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. Sage Publications.
Sheller, M., & Urry, J. (2006). The new mobilities paradigm. Environment and Planning A, 38(2), 207-226.
Sontag, S. (1977). On Photography. Farrar, Straus and Giroux.
Urry, J. (1990). The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies. Sage Publications.
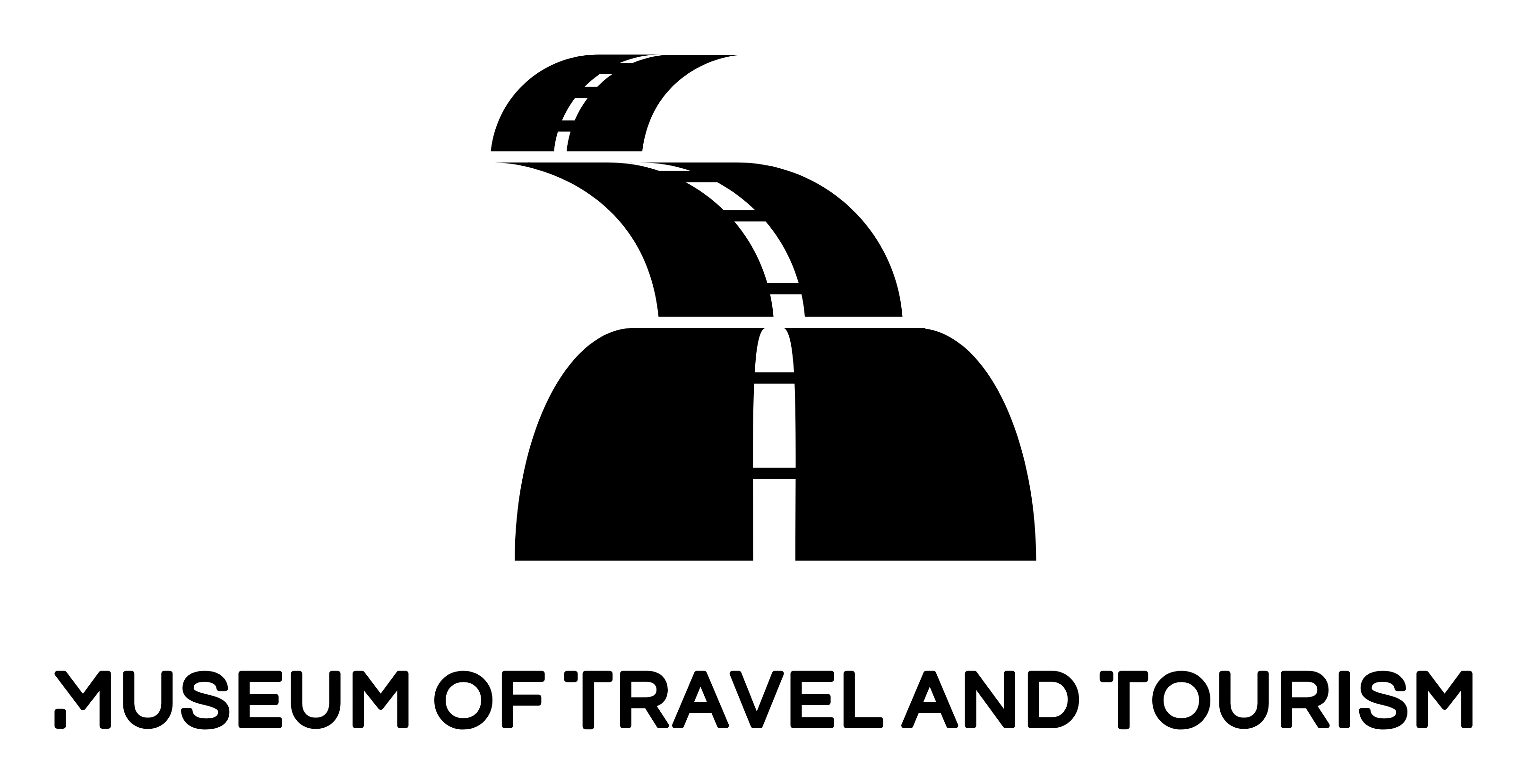
 Italiano
Italiano  Français
Français  Deutsch
Deutsch  English
English 